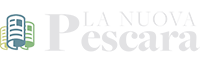di Marco Presutti*
L’audizione del cardinale Baldassare Reina, vicario generale per la diocesi di Roma, presso la Commissione parlamentare d’inchiesta sul degrado delle città e delle periferie, avvenuta l’8 aprile scorso, offre spunti di riflessione che travalicano i confini della capitale e interpellano direttamente la nostra realtà locale, in particolare nel momento cruciale che stiamo vivendo con il percorso verso Nuova Pescara. Le parole del cardinale, incentrate sulle dinamiche di disuguaglianza, marginalizzazione e sulla necessità di un nuovo approccio all’urbanistica e alla coesione sociale, rappresentano una bussola preziosa per chi oggi è chiamato a disegnare il futuro della nostra città allargata.
Le periferie esistenziali
Nel suo intervento il cardinale Reina ha dipinto un quadro lucido e a tratti drammatico della situazione romana, evidenziando come le periferie non siano solo luoghi geografici ai margini, ma sempre più spesso periferie esistenziali. Ha parlato di un tessuto sociale frammentato, di disuguaglianze crescenti che si manifestano nell’accesso alla casa, ai servizi, all’istruzione, alla sanità. Ha sottolineato la solitudine che colpisce molti, giovani e anziani, la fatica dell’integrazione per i migranti, la mancanza di spazi di aggregazione sani e la difficoltà nel creare un senso di comunità autentica.
Uno specchio per Pescara: dinamiche familiari
Seppur con scale e contesti differenti, quante di queste dinamiche risuonano familiari anche a Pescara e nell’area metropolitana che presto si unirà formalmente? Anche il nostro territorio conosce le sue periferie, non solo geografiche (pensiamo a Rancitelli, Fontanelle, ma anche a certe aree interne dei comuni che entreranno in Nuova Pescara), ma anche sociali ed economiche. La difficoltà abitativa per le fasce deboli, la disoccupazione giovanile, le sacche di povertà, le sfide dell’integrazione e la necessità di rafforzare i legami comunitari sono temi presenti e urgenti anche qui. L’analisi del cardinale Reina per Roma, quindi, non è un racconto lontano, ma uno specchio che riflette problematiche universali delle città contemporanee, Pescara inclusa.
Nuova Pescara: oltre l’adempimento burocratico, il dovere dell’ascolto
Ci siamo detti molte volte che il processo di fusione tra Pescara, Montesilvano e Spoltore rappresenta un’occasione storica. Tuttavia, il rischio è che ci si concentri unicamente sugli aspetti amministrativi, burocratici o sulla pianificazione urbanistica intesa solo come infrastrutture e cemento, trascurando la dimensione umana e sociale. Le parole del cardinale Reina arrivano come un monito potente: la politica ha il dovere di porsi in atteggiamento di profondo ascolto. Ascolto delle fragilità, delle voci inascoltate che provengono proprio da quelle periferie geografiche ed esistenziali. Costruire la Nuova Pescara non può significare semplicemente sommare territori e
popolazioni. Deve essere l’opportunità per ripensare la città in chiave più equa, inclusiva e solidale. Significa chiedersi: che tipo di città vogliamo? Una città che accentua le divisioni o una che lavora per ricucirle? Una città che lascia indietro i più deboli o una che investe sul loro riscatto?
Una visione concreta per il futuro: benessere, comunità, partecipazione Dobbiamo sentirci interpellati dalle parole del cardinale, come se le avesse rivolte direttamente a noi, richiamando la responsabilità della politica nel promuovere il bene comune. La nascita della Nuova Pescara richiede un salto di qualità: superare la gestione dell’ordinario e la logica amministrativa per abbracciare una visione politica di lungo periodo, capace di incidere sulle cause profonde del degrado e delle disuguaglianze. Ascoltando gli appelli come quello del cardinale Reina e traendo ispirazione da approcci come l’economia civile (Bruni) e la misurazione del benessere integrale (Becchetti), questa visione deve mettere al centro la persona e la comunità, puntando a uno sviluppo realmente equo e sostenibile. Concretamente, ciò significa impegnarsi in una rigenerazione urbana che sia innanzitutto sociale e partecipata: intervenire nelle periferie non solo con opere edilizie, ma co-progettando con i residenti spazi pubblici di qualità, case di quartiere che fungano da poli di servizio e aggregazione, e favorendo la cura condivisa dei beni comuni. Parallelamente, è cruciale promuovere attivamente un’economia più inclusiva e generativa: sostenere le cooperative e le imprese sociali che creano valore sul territorio, utilizzare gli appalti pubblici come leva per la responsabilità sociale e ambientale, e trasformare il welfare da mera assistenza a motore di emancipazione attraverso la formazione e l’inserimento lavorativo, specialmente per i giovani e le fasce deboli. Infine, questa visione deve investire strategicamente sulla coesione sociale e sulla comunità educante: potenziare i servizi educativi, culturali e sportivi come presidi territoriali accessibili a tutti, sostenere le reti associative che animano la vita comunitaria e promuovere attivamente il dialogo interculturale e intergenerazionale.
La sfida aperta: da fusione a comunità solidale
Solo adottando questa prospettiva integrata e coraggiosa, misurando i progressi non solo in termini economici (PIL) ma di Benessere Equo e Sostenibile (BES), la Nuova Pescara potrà diventare non solo una città più grande, ma una comunità più giusta, solidale e capace di futuro per tutti i suoi cittadini. L’analisi del cardinale Reina ci ricorda che il degrado urbano è quasi sempre riflesso di un degrado sociale e umano. Ignorare queste dinamiche nel progettare la Nuova Pescara significherebbe costruire una città forse più grande, ma non necessariamente migliore. Cogliere la profondità di questo messaggio e tradurlo in azioni concrete è la vera sfida per la politica locale nei prossimi anni. È un’occasione per dimostrare che la fusione non è solo un atto formale, ma l’inizio di un percorso per una città davvero nuova, più giusta e attenta ai suoi cittadini, a partire dagli ultimi.
*Consigliere del Pd al Comune di Pescara ed ex assessore alla Nuova Pescara