
di Ermanno De Pompeis*
Oltre i luoghi comuni che ancora oggi dominano la storiografia regionale, gli Abruzzi hanno sempre avuto anche una vocazione marittima che smentisce la presunta carenza di porti e approdi naturali. Hatria, Aternum, Ortona e Histonium sono solo alcuni dei principali scali marittimi che già in epoca pre-romana testimoniano degli scambi commerciali che avvenivano via mare pure con l’altra sponda dell’Adriatico, sviluppando un’economia costiera integrata e funzionale all’entroterra agricolo.
Fino all’avvento delle ferrovie, il trasporto delle merci e delle derrate alimentari per secoli era stato garantito principalmente dai navigli mercantili: dalla Repubblica di Venezia le merci impiegavano circa 11 giorni fino ad arrivare ai porti di Pescara e di Ortona, centro a sua volta collegato alle rinomate e antichissime fiere di Lanciano; lo stesso tempo che occorreva con i carri trainati dal bestiame per il trasporto terrestre attraverso la Via degli Abruzzi, antico itinerario che collegava Firenze a Napoli passando per L’Aquila.
Parallelamente al commercio marittimo, i fondali bassi e ricchi di nutrienti dell’Adriatico hanno da sempre favorito lo sviluppo della pesca svolta secondo metodi e mezzi tradizionali, come per le tipiche imbarcazioni dalla chiglia quasi piatta, adatte all’avvicinamento alla riva dove potevano essere tirate in secco in caso di maltempo, seguendo consuetudini tramandate di padre in figlio rimaste pressoché immutate nei secoli. Molti erano gli uomini di mare che svolgevano alternativamente le attività di marinai e pescatori, così come le barche da pesca potevano essere stagionalmente adibite al trasporto di derrate.
Una cultura marinara i cui tratti comuni sono stati determinati dall’esperienza e dal rapporto quotidiano con il mare, nel contesto di una continuità storica legata alla plurisecolare influenza della marineria veneziana. Con la fine della potenza marittima di Venezia – che aveva consentito grossi volumi di affari al traffico mercantile gestito dalla Repubblica – le attività di pesca, svolte per lo più a carattere familiare e privato, diventano predominanti nell’economia locale. Raccolti in piccole comunità affacciate sul mare e vicini ai propri mezzi di sussistenza, i pescatori hanno sviluppato nel tempo una diversità culturale dettata dalle mutevoli situazioni meteo marittime e dalle stagioni che ne hanno condizionato le abitudini e i ritmi di vita, sia lavorativa che familiare; isolati nei loro quartieri
di povere casupole – edificate spontaneamente le une vicine alle altre in prossimità di magazzini e caotici spazi esterni di lavoro – la vita di questi gruppi sociali si svolgeva prevalentemente all’aperto. I marinai erano imbarcati, a volte per giorni, sulle caratteristiche paranze e sui barchitti in legno e praticavano la pesca a strascico sospinti solo da variopinte vele al terzo, procedendo con due scafi appaiati al paro, in modo da tenere aperta la bocca della rete che li univa. Sulla spiaggia e sulle banchine dei porti la sera rientravano dal mare gli equipaggi, aiutati dagli sbalzocchi o sbarzocchi a seppellire sotto la sabbia le pesanti ancore e a trasportare a riva il pescato, mentre le donne si preparavano a vendere abilmente la scafetta, la parte di pesce spettante ai marinai per la sussistenza. Di giorno fervevano le attività di piccola pesca dalla riva, gli anziani
retieri – chiamati armacchiatori – riparavano le reti con maestria, gli esperti calafati provvedevano alla manutenzione periodica degli scafi costruiti da maestri d’ascia locali; c’erano poi i cordai e le donne addette alla preparazione dei panire e delle coffe – ceste in giunco per traportare il pescato – e tanti altri mestieri che
garantivano l’autoproduzione dei beni necessari alla sussistenza del gruppo sociale.
La dura vita dei murè, i mozzi bambini
La dura vita di bordo era regolata da una ferrea gerarchia, comandata dal parone che disponeva sui marinai, sui giovanotti e sui murè-i mozzi bambini addetti ai lavori più umili e imbarcati per imparare il mestiere – mentre a terra i ruoli sociali erano suddivisi in maniera più equa e funzionale alle diverse esigenze. Qui la
figura femminile travalicava i tradizionali compiti domestici, svolgendo una mansione essenziale per la sopravvivenza della famiglia, dedicandosi alla vendita del pesce spettante ai marinai ed al baratto che spesso avveniva con altre merci necessarie al sostentamento. Essere pesciarola significava aver svolto un lungo
apprendistato, con le mamme prima e con le suocere una volta sposate, per sviluppare le abilità necessarie al commercio da banco e alla contrattazione che ne scaturiva con i compratori, essendo spesso in competizione con le altre donne dedite allo stesso mestiere. In questo sistema economico familiare erano le
madri che davano il proprio assenso ai figli per sposarsi, in un contesto dove la libertà di scelta era condizionata dall’appartenenza allo stesso ceto sociale ed al medesimo sistema produttivo.
La prevalente omogamia matrimoniale, che acuiva l’isolamento culturale oltre che fisico di queste comunità, era tuttavia
aperta all’arrivo e all’integrazione di nuovi gruppi familiari di pescatori, come avvenne sulle coste abruzzesi alla fine del Seicento, con diversi gruppi veneti provenienti da Chioggia e Caorle o nella seconda metà dell’Ottocento con altre consistenti migrazioni in arrivo dalle Marche.
La diffidenza con la quale erano visti gli abitanti dei quartieri marinari dagli altri ceti sociali non impediva loro di entrare in stretti rapporti economici con il circondario: quando negli ultimi decenni dell’Ottocento i collegamenti ferroviari facilitarono l’espansione sulla costa dell’emergente ceto sociale borghese – prima per la moda della villeggiatura e dei bagni di sole contro il diffondersi della tubercolosi e del rachitismo, poi per lo sviluppo dei centri produttivi e dei traffici commerciali – sarà proprio la crescente domanda di prodotto ad incrementare il numero di barche e degli abitanti dei borghi marinari. Gli scambi commerciali avvenivano
anche con i centri collinari attraverso i viaticari che, con carri trainati da animali, trasportavano il pescato fin nelle contrade.
La sciabbeche, lu ciucculare e lu travocche
Allo scoppio della Prima Guerra Mondiale, nei registri della gente di mare del circondario marittimo di Ortona dov’erano ricompresi gli approdi di Termoli, Vasto, San Vito, Francavilla, Pescara, Rosburgo ( Roseto) e Giulianova – risultavano iscritti 3772 pescatori e censite 377 barche da pesca, di cui 200 nei porti più grandi
di Ortona e Pescara. Tuttavia, le attività di pesca erano varie e non si svolgevano solo con le paranze in mare aperto, ma anche da riva con piccoli battelli e reti di vario tipo, come la sciabbeche (rete a strascico), oppure con nasse ed attrezzi come lu ciucculare per la pesca di vongole e telline. Un posto speciale dev’essere riservato alla pesca con lu travocche, una tecnica con reti a bilanciere tra le più antiche e diffusa nell’Adriatico, ma che nella costa frentana assume connotazioni specifiche; qui le tipiche costruzioni
in legno dalla costa si spingono fin dentro al mare, con palafitte piantate sugli scogli emersi e collegate alla
terraferma tramite passerelle. Documentata l’esistenza di trabocchetti con reti a bilanciere nel mare
sottostante l’Abbazia di Fossacesia fin dal 1240, i primi traboccanti non erano pescatori ma agricoltori che dal mare traevano stagionalmente il sostentamento necessario per integrare gli scarni raccolti delle terre costiere, poco produttive perché rocciose e scoscese.
Il segno di Salomone per esorcizzare lu scijone
La precarietà delle condizioni di vita, connesse all’imprevedibilità delle condizioni del mare e dei venti, assegnava un ruolo importante all’osservazione della natura e all’esperienza dei marinai più anziani che sapevano interpretarla. Quando alle difficoltà impreviste non si trovava rimedio attingendo al patrimonio di conoscenze realistiche, si faceva ricorso alle tecniche di superamento simboliche tipiche della cultura folklorica, mettendo in atto rituali che consentivano di esorcizzare l’evento. Esempio di tale cultura sono le
formule adottate per tagliare lu scijone, tromba marina che si credeva generata da spiriti malefici. Per scongiurarla un marinaio, figlio primogenito imbarcato doveva tracciare con un coltello dal manico nero il segno pentacolare di Salomone nell’aria o sull’albero maestro della barca, conficcandovi nel mezzo il
coltello mentre recitava una formula scongiuro trasmissibile dai più anziani solo nella notte di Natale.
Anche il varo prevedeva l’entrata in mare di poppa, per poter permettere alla paranza di vedere e ricordare la spiaggia dalla quale era partita e farvi ritorno. Nella trasposizione simbolica lo scafo diventava, infatti, un soggetto animato antropomorfo sul quale apporre o dipingere di rosso (contro l’invidia) dei grossi occhi a
forma di virgola rovesciata, le cui pupille erano i due fori per le ancore di prua; secondo un’antica tradizione, diffusa in tutto il mediterraneo, questi occhi dovevano scrutare la rotta ed evitare gli ostacoli in mare.
Nell’ambito delle procedure simboliche a volte si mescolano le intenzioni propiziatrici – come quelle evidenti nei brevi, piccoli scapolari contenenti sostanze diverse e amuleti come i cavallucci marini – con le finalità più spiccatamente difensive, laddove il segno della croce, la benedizione e i santi vengono sincreticamente invocati a protezione dai pericoli e per la domesticazione del mare, dimensione aliena rispetto al terrestre.
Il lavoro del mare non offriva solo un modo per sopravvivere, ma rappresentava una dimensione identificativa e consapevole del proprio status, ostentato con orgogliosa convinzione. Del resto, l’iniziazione al rapporto col mare avveniva molto presto, intorno agli otto anni: imitando il mestiere del padre ci si
imbarcava come murè sotto padrone – per consuetudine non si andava nella barca dove c’era il genitore – e si imparava subito il duro lavoro di mozzo di bordo, sgottando continuamente l’acqua in sentina ed arrampicandosi pericolosamente sui pennoni per legare o sciogliere le vele, senza mai dimenticare la ferrea legge marinara che imponeva, se necessario a suon di percosse, il massimo rispetto per le persone anziane.
Non andava meglio quando da adolescenti si diventava giovanotti, con il compito altrettanto gravoso di dormire a bordo su umide reti e riparati solo dalla murata (fianco) della paranza, in perenne attesa della chiamata notturna per uscire in mare. Nudi si doveva allora scendere in acqua anche in inverno per andare a
prendere i marinai e trasportarli sulle spalle a bordo delle barche, poi bisognava bagnarsi di nuovo per andare a ritirare le pesanti ancore di poppa seppellite sotto un metro di sabbia.
Uno stile di vita fatalistico fondato sull’addestramento alla fatica e sulla competizione, resa necessaria dalla capacità di sapersi imporre all’attenzione del parone, il quale poteva disporre delle parti del pescato da distribuire ai marinai in maniera non uniforme. La rivalità all’interno della categoria si rivela un elemento qualificante l’esercizio del mestiere e diventa un motivo di orgoglio identitario, a volte oltre le ragioni di carattere esclusivamente economico.
D’altronde la pesca è una forma di predazione naturale che genera intrinsecamente antagonismo con gli altri concorrenti, non solo esterni al gruppo ma anche per stabilire le gerarchie. Tuttavia la competizione si trasforma in maniera altrettanto forte in complicità e solidarietà in caso di pericolo dell’individuo o del gruppo sociale di appartenenza.
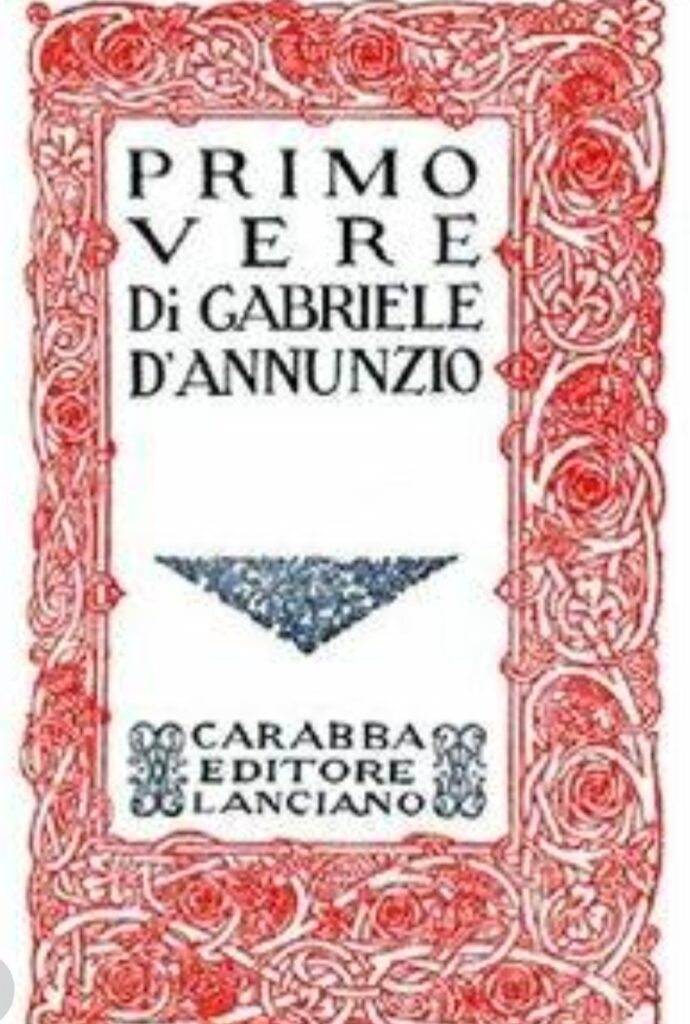
“Il mare è… la Patria dei liberi” ,scriveva Gabriele D’Annunzio nel Primo Vere ed in effetti proprio lo spirito d’indipendenza, non inquadrabile in categorie padronali o salariate – ricoprendo spesso il doppio ruolo di lavoratori e di datori di lavoro – rendeva i pescatori ostili a qualsiasi forma di inquadramento, sia giuridico
amministrativo che sindacale. Nel momento in cui, nel secondo Dopoguerra, arriva anche in questo settore l’industrializzazione – con la diffusione dei motori e della strumentazione tecnica – la trasformazione dei pescherecci e dei metodi di pesca, connessa alla propagazione del lavoro salariato, mette in crisi un modello
sociale e culturale rimasto pressoché immutato per secoli. Di fronte a tale scenario, proprio la percepita alterità ed estraneità della cultura marinara, non ha favorito l’interesse e l’attenzione da parte degli studiosi e delle classi colte verso la salvaguardia e la conservazione delle sue ultime tracce materiali e spirituali;
diversamente da quanto accadde per il mondo agro-pastorale, forse più vicino al concetto borghese di terra e di territorio, nel passato non si è riusciti ad andare oltre la romantica visione delle vele colorate e dei paesaggi marini descritti dai pittori e raccontati dai poeti; più tardi, non essendo la gente di mare inquadrabile quale classe popolare subalterna impegnata nelle lotte per il riconoscimento dei diritti dei lavoratori del proletariato operaio e contadino, anche lo storicismo gramsciano prevalente negli studi demo- antropologici ha messo in dubbio l’esistenza di una definita cultura del mare. Il disagio interpretativo, forse
più che l’esigua consistenza numerica dei pescatori, oltre al rapido deperimento della cultura materiale che le afferiva, probabilmente spiega i pochi musei dedicati alle marinerie tradizionali e la penuria di reperti oggi conservati, nonostante l’Italia sia circondata dal mare.
Oggi, l’esposizione al Museo delle Genti d’Abruzzo di Pescara dedicata alle locali marinerie tradizionali intende offrire un primo contributo di indagine e di riflessione su alcune dimensioni storico-culturali dei nostri pescatori, tentando di collocarne la specificità e l’autonomia relative alla loro esperienza marinara all’interno della storia delle culture delle genti d’Abruzzo.
*Curatore della sezione espositiva Genti di Mare e Conservatore del Museo delle Genti d’Abruzzo

