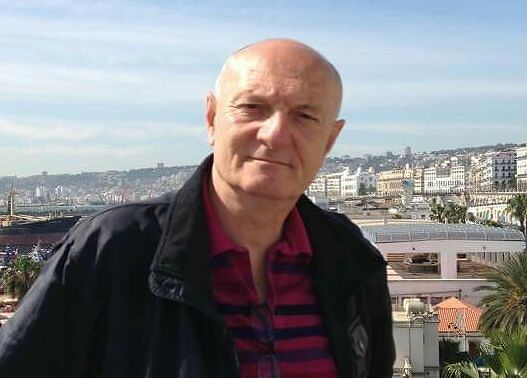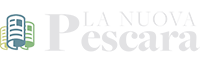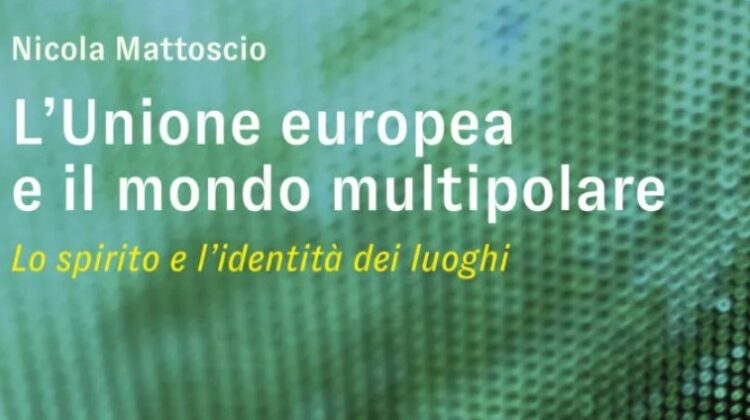
Gli articoli e i saggi che Nicola Mattoscio raccoglie nel suo nuovo libro – L’Unione europea e il mondo multipolare (Rubettino Editore) – sono legati dal filo rosso delle nuove prospettive europee maturate in conseguenza della pandemia, dell’aggressione russa all’Ucraina e della nuova guerra tra israeliani e palestinesi dopo la strage di Hamas e la rappresaglia disumana e sproporzionata nella striscia di Gaza. Il tutto si colloca in uno scenario mondiale di grandi contrapposizioni militari ed economiche tra Europa e Russia, tra Stati Uniti e Cina, tra Occidente e resto del mondo con un crescente protagonismo dei Paesi Brics allargati a nuove varie potenze economiche e militari regionali emergenti.
I vari capitoli composti dagli articoli di Mattoscio sono introdotti da riflessioni originali e stimolanti, e sono raggruppati prevalentemente in ordine cronologico e, comunque, per tematiche omogenee. Per questo hanno una logica coerenza e facilitano il lettore nella comprensione di mutamenti complessi che hanno sconvolto l’orizzonte dell’ economia e della geopolitica mondiale.
I primi tre capitoli si soffermano sulle lezioni del secolo belva, definizione che Mattoscio utilizza per descrivere il novecento affiancandola a quella famosa del grande storico inglese dell’Università di Cambridge Eric Ernest Hobsbawm a cui si deve la formidabile suggestione del “secolo breve”. Mattoscio in questa intuizione avvalora la visione sociale del pensiero storico di Hobsbawm che ebbe modo di scrivere: ” La memoria è vita. Essa è in perpetua evoluzione. Rimane a volte latente per lunghi periodi e poi ad un tratto rivive. La storia è la ricostruzione sempre incompleta e problematica di quello che non è più. La memoria appartiene sempre al nostro tempo e forma un eterno presente. La storia invece è rappresentazione del passato.” ( L’ Età degli imperi di E. Hobsbawm)
Mattoscio, partendo da episodi legati all’economia e alla vita delle persone, rappresenta una visione della storia che parte dal basso e mette insieme molti tasselli, dalle migrazioni alla transizione ecologica, dell’economia digitale ai diritti umani e civili, che ci portano a comprendere il quadro storico contemporaneo così complesso e affascinante. I successivi tre capitoli si soffermano sulla pandemia, sulla risposta europea di impianto keynesiano contenuti negli obiettivi del Recovery Plan e sullo sconvolgimento determinato dalla guerra tra Russia e Ucraina con i nuovi scenari geopolitici e geoeconomici che accentuano il disordine mondiale e complicano di molto la ricerca di un nuovo equilibrio basato su un orizzonte multipolare e su una civiltà che sia in grado di rappresentare i valori permanenti della democrazia e dei diritti umani di libertà, giustizia e pace.

L’ultimo capitolo ci propone una visione d’insieme sui fenomeni contemporanei della nuova guerra tecnologica tra Usa e Cina nel momento in cui la guerra è così prepotentemente rientrata in Europa e continua ad insanguinare il medio Oriente per la storica incapacità dell’Occidente di non aver garantito la sicurezza di Israele e il diritto ad uno Stato indipendente della Palestina, nonostante 70 anni di conflitti, rivolte, deportazioni e ricorrenti fallimentari trattative.
La postfazione di Mattoscio attualizza l’analisi e fornisce una chiave di lettura generale sui guasti provocati da una globalizzazione anarchica e dalla sproporzionata importanza dei sistemi industriali e militari nell’economia mondiale che hanno finito col danneggiare le attività di scambio e di libero commercio, e in particolare l’approvvigionamento di materie prime e beni energetici, con riflessi catastrofici sull’andamento dell’economia internazionale e sulla condizioni di povertà e di benessere della parte più bisognosa della popolazione mondiale.
Mattoscio non si piega alla vulgata delle forze conservatrici di un’Europa ormai “stanca, invasa, debosciata”, vinta dalle troppe promesse di libertà civili e sociali che ne hanno minato l’identità, illusa da una strategia sovranazionale che non fa i conti con la supremazia dei popoli di ognuno dei 27 stati europei che viene prima del “federalismo” senza Costituzione dell’Unione Europea.
A Mattoscio non piace una simile visione sovranista che preferisce tante “piccole patrie” rispetto all’integrazione federalista dell’Unione Europea dal campo monetario a quello fiscale e sociale, dalla difesa ai diritti civili e di libertà.
Il suo pensiero è quello dei Padri fondatori dell’unità europea e ha un riferimento teorico, politico e morale nel manifesto di Ventotene di Spinelli quando ancora il fascismo e il nazismo insanguinavano l’Europa con la guerra e l’Olocausto, ed era molto difficile pensare all’unità dell’Europa su una base federalista.
Naturalmente l’europeismo di Mattoscio non è un solo sogno utopistico, ma si basa su opzioni ragionevoli e pragmatiche, funzionali agli interessi dei cittadini europei, alle loro libertà e al loro benessere economico e sociale. Per questo Mattoscio considera favorevolmente la proposta di riforma dei Trattati varata dal Parlamento Europeo il 22 novembre 2023 che va nella direzione di una Federazione di Stati Europei. “Un’ Unione Europea federale, perciò stesso più democratica ed efficace, nonché più incisiva sui diritti dell’uomo e sulla sostenibilità ambientale e digitale, sarebbe nel contempo a vantaggio dei suoi cittadini e da stimolo per una nuova ondata globale di democratizzazione.” Ed è naturale in questa visione di Mattoscio l’incontro con la migliore radice della cultura cristiana, quella della tolleranza, della solidarietà e della pace che ha spinto Papa Francesco ad esortare l’Europa a riscoprire la sua anima più autentica per tornare ad essere un “prezioso punto di riferimento per tutta l’umanità”.
Gianni Melilla