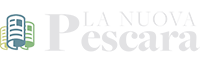La bandiera dell’Impero Romano d’Oriente
di Raffaele Morelli*
Per capire quando l’essere umano primordiale ha sviluppato la convinzione che esistesse un livello superiore a quello percepibile con i cinque sensi, dobbiamo risalire all’inizio della preistoria. I primi segnali che provano il passaggio da un pensiero immanente ad un pensiero trascendente risalgono al periodo precedente all’avvento dell’Homo sapiens, le prime testimonianze sono riconducibili alle pratiche funerarie, cioè al Paleolitico Superiore che possiamo collocare intorno ai 35.000 anni fa. Le nostre conoscenze derivano dai ritrovamenti attraverso cui desumiamo la nascita del senso religioso e magico. Questa caratteristica è presente esclusivamente nell’uomo. Nessun animale è
in grado di spostare il pensiero dal mondo dei sensi a quello delle idee (vedi Max Scheler – La posizione dell’uomo nel cosmo – 1928). Cosa è cambiato da allora? Da allora, l’unica vera differenza tra noi e i nostri antenati consiste nella strutturazione sociale della ritualità connessa alla percezione del sacro.
Ai primordi, il vissuto del sacro era l’espressione individuale della necessità di dare una risposta a domande fondamentali sulla collocazione dell’essere umano nel rapporto con la vita e la morte e di aprire uno spiraglio nel buio assoluto che lo contornava. L’uomo preistorico era così anche in grado di elaborare, in forma mitica o logica, l’idea di qualcosa
che andava oltre la natura che lo circondava. Sulla cima dell’idea di potenza soprannaturale si colloca Dio, così prende forma il legame che unisce metafisica e religione. La semplicità del rapporto individuale del Paleolitico superiore, si sviluppa, in seguito in modo sociale, strutturandosi all’interno delle tribù e allargandosi da una tribù alle altre. Quando, nel mondo occidentale, possiamo collocare l’inizio dell’era politica della religione che si era strutturata in precedenza come l’esplicazione del mondo sconosciuto in quello conosciuto? Per capirlo dobbiamo prima fermarci al mondo pre-ellenistico e greco. Gli uomini preistorici avevano tutti, più o meno, gli stessi problemi. È ipotizzabile che tutti dessero le medesime risposte trascendenti alle domande senza risposta derivanti dalle esperienze quotidiane. La religiosità tentava di spiegare la realtà affidando ogni parte di essa ad un dio diverso, contrapponendosi alla filosofia, che, invece cercava risposte all’interno delle capacità logiche. A Giove la protezione dai fulmini a Venere la
protezione della riproduzione e così via. Questo periodo non è ancora un periodo in cui la politica entra nei processi religiosi. Non abbiamo notizie di scontri tra tribù e popoli conseguente alle diverse interpretazioni religiose. Gli dèi cambiano nome a seconda delle lingue parlate dalle diverse popolazioni ma, più o meno, conservano le proprie caratteristiche. Ad esempio, l’Olimpo greco si trasferisce nella cultura romana senza alcuno scossone sociale, segno che più che l’identità personale contava il campo in cui l’attività del dio prendeva corpo.
Prima del cristianesimo l’unico popolo che non si integrava nella cultura religiosa presente in Europa era il popolo ebraico. La religione ebraica monoteista nasce nel Tanakh, il libro che racconta le origini del popolo ebraico. Il testo sacro parte dalla creazione del mondo e denuncia il progressivo distacco dell’umanità dalla subordinazione all’unico Creatore. Per questo Dio crea ed educa un popolo che dovrà essere maestro degli altri popoli nel ricondurli sulla strada del monoteismo. Gli
ebrei hanno subito delle persecuzioni, come tutti sanno, fin dall’inizio della loro nascita come popolo, ma possiamo affermare che tali espressioni politiche non fossero ancora sufficienti a rendere giustificabile una politicizzazione della religione. Erano più uno scontro tra differenti modi di concepire la vita sovrannaturale. La rivoluzione assoluta ha inizio con la nascita della religione Cristiana. Partendo da quelle che erano le credenze contenute nella religione ebraica, Cristo non poteva non nascere in Palestina, che era all’epoca, la culla del monoteismo occidentale. Dalla Palestina, il cristianesimo si trasferisce a Roma, che, nel frattempo, è diventata la potenza dominatrice di tutto il mondo euroasiatico. Ed è proprio a Roma che la religione acquisisce una valenza politica. Di chi la responsabilità della trasformazione? Del potere politico romano allora nelle mani degli imperatori. Si deve a Nerone, infatti, nel 64 D.C. la promulgazione degli editti, poi diffusi in tutto l’Impero romano, che istituivano la persecuzione dei cristiani. È questo, dunque, il punto di non ritorno nell’evoluzione della religiosità in religione. È l’anno 64 D.C.. l’anno in cui trova origine un cambiamento epocale che si completa con la nascita della religione islamica nei primi anni del VII° secolo Dopo Cristo.
La nuova religione vede la luce a La Mecca grazie alla predicazione di Maometto e nasce come fatto religioso, ma soprattutto politico. Nasce in opposizione alla religione monoteistica cristiana ormai praticata ovunque all’interno del mondo occidentale esteso fino alla Turchia. Nasce per volontà del suo Profeta, con regole completamente diverse da quelle professate nel cristianesimo, con il quale si trova in piena contrapposizione. Siamo nell’Alto Medioevo, e l’avvento dell’islamismo è una delle condizioni che porteranno, nel 1453, alla caduta dell’Impero Romano d’Oriente due millenni e mezzo dopo la nascita di Roma. Da questo momento in poi, la religiosità è stata soppiantata dalla religione.
Le tracce dell’arcaico sentire religioso dell’uomo sono confinate nella mente dei singoli. All’inizio, dal momento in cui l’Imperatore Costantino sostituisce le religioni politeistiche con il cristianesimo, iniziano le vendette: la persecuzione e l’eliminazione fisica dei non cristiani sono la risposta alle persecuzioni che questi ultimi hanno dovuto subire nei decenni precedenti. Ma con Costantino ha inizio un’altra grande differenza tra la religione e il potere. La religione diventa il piedistallo su cui salire per giustificare
l’ineluttabilità del potere, in senso politico assoluto. Chi viene designato alla guida del popolo ha il marchio della trascendenza. I re vengono incoronati nelle chiese e dunque uniscono il potere derivante dalla forza terrena, cioè il potere militare, con quello derivante dalla forza divina. Nulla è più alto e incontrovertibile. Questo passaggio si rende necessario perché in occidente la forza della Chiesa, che nel frattempo si è costituita sotto il vessillo di Gesù Cristo e che, nel papato, assurge a potere soprannaturale e terreno, con tanto di esercito a difesa, è troppo diffusa come religione e troppo forte, anche militarmente, per essere tolta di mezzo. Per questo, il potere politico deve allearsi con quello religioso per blindare una credibilità inoppugnabile. Ed è ciò che avviene se
teniamo conto che ancora ai giorni nostri, l’incoronazione di Carlo d’Inghilterra è avvenuta
nell’Abbazia di Westminster ad opera di un prete anglicano, cioè di una branca del cristianesimo costituita in opposizione al potere papale da Enrico VIII nel 1534, che ne divenne il capo. Da allora i due poteri, terreno e celeste, hanno continuato a marciare affiancati sia nell’occidente che nell’Oriente Islamico. Lo sviluppo e il non sviluppo politico e sociale dei due mondi è conseguenza dell’atteggiamento del potere religioso che, in oriente, ha sostituito anche il potere politico facendo la strada al contrario rispetto a quando accaduto in Occidente. Della religiosità non sono rimaste tracce nella società moderna e chi la professa al di fuori della religione lo fa in maniera privata, come era agli albori.
*medico e romanziere pescarese, ha da poco pubblicato ‘Voglio tornare al topless bar’ (All Around).