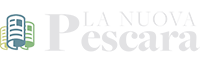di Ernesto Grippo*
Un concerto in riva al mare con le canzoni abruzzesi arrangiate da un maestro di tutto rispetto, Enrico Melozzi, e cantanti famosi che declinano nel nostro dialetto alcuni brani è una rivoluzione culturale attesa da anni? Lo ha sostenuto proprio l’ideatore della Notte dei Serpenti, Melozzi.
A prescindere dalla scena non bella del Maestro di farsi fonare i capelli in teatro con ripresa Rai “per non perdersi” le prove, è bene ricordarci che la cultura popolare abruzzese è una cosa complessa, un patrimonio che merita rispetto. La rivoluzione culturale di un popolo poi attiene tanti ambiti e quello della canzone non è certo al primo posto. A chi vuole entrare a tutto tondo nella cultura popolare abruzzese basterebbe aprire e soprattutto leggere lentamente il volume Scrittura e radici per i tipi della Rocca Carabba editore.
L’opera raccoglie i saggi del professore Ottaviano GIannangeli, ordinario di dialettologia dell’Università Gabriele D’Annunzio. Il letterato raianese ci regala analisi critica e storica della scrittura dialettale come coerenza in un sistema soggettivo e cita i vari Cirese, Clemente, de Titta e Della Porta. Di Clemente ne analizza l’opera omnia , per poi soffermarsi su Nu cante suspirose di parole, di Luigi Dommarco, autore di Vola Vola. E accompagnarci per mano nei colori e nei suoni della poesia dialettale di Cesare De Titta e nel privilegio dei tria corda, Giannangeli non tralascia l’illuminismo popolare di Modesto Della Porta. Racconta l’anarchico, maestro e poeta Umberto Postiglione per poi regalarci uno spaccato su Vittorio Monaco e la sua lingua morta. Senza dimenticare il canzoniere Walter Cianciusi. Non manca un esame attento dell’opera in dialetto di Alfredo Luciani che Pierpaolo Pasolini, nella sua antologia, considera tra i grandi poeti del novecento.
A Pescara, corre l’anno 1952, quando uomini del calibro di Fiorentino, Merciaro, Sechini, Teodori, Fabiano, Prosperi, Gizzi e il sindaco Chiola sentono l’esigenza di amplificare il canto popolare e la canzone dialettale d’autore (due cose ben distinte) e danno vita alla Settembrata Abruzzese.
Da quel giorno per almeno 14 lustri, sotto la guida nelle ultime decadi di Antonio De Laurentiis, Camillo De Leonardis e Antonio Luise, il dialetto in versi, il vernacolo nelle commedie e la parlata paesana nelle canzoni soprattutto quando eseguite a due voci, hanno contraddistinto l’identità di un popolo.
La commedia dialettale è stata apprezzata oltreoceano nelle interpretazioni di Gino Cecamore, e con la tragedia della Figlia di Iorio nella traduzione in dialetto del 1923 fatta da de Titta su richiesta del Vate D’Annunzio, messa in scena per la regia di Danilo Volponi, si è scritta una pagina di storia.
Il concerto in riva al mare con centinaia di coristi e ospiti canori internazionali è un evento molto importante, ma “cosa mi dici mai?” direbbe Topo Gigio, uno degli invitati, della rivoluzione culturale abruzzese. La stiamo attendendo da decenni, la rivoluzione, e ben venga, ne abbiamo un gran bisogno.
*Comandante Polizia locale Roseto degli Abruzzi