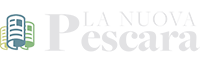di Giampiero Leombroni*
Le continue notizie di stampa su una presunta crisi idrica, stanno facendo maturare
nell’opinione pubblica il convincimento che tale crisi possa dipendere dalla scarsezza della risorsa e dalla sua dipendenza dagli eventi climatici. Nessuna attenzione viene riservata alla condizione strutturale delle reti di adduzione e distribuzione idrica, particolarmente per quelle incidenti sulle aree urbane più densamente abitate, la cui manutenzione e adeguamento – a datare dalla fine del secolo scorso – sono state a dir poco inadeguate rispetto all’incremento della popolazione insediatasi sulla costa abruzzese e all’aumento delle dotazioni giornaliere per abitante.
I mezzi di informazione, dal canto loro, non fanno che amplificare allarmismi ingiustificati,
omettendo di approfondire quali siano le vere ragioni che sottendono alle difficoltà di distribuzione idrica nel territorio regionale. Per avere contezza della reale situazione abruzzese è bene partire da un assunto inequivocabile: l’Abruzzo è una delle regioni italiane con maggiore disponibilità di risorsa sorgentizia. Infatti, solo considerando le sorgenti con maggiore apporto idrico è oggettivo riscontrare volumi dell’ordine di 50 mc/sec di acqua potabile diffusi sull’intero territorio regionale.
Qualora si volesse rapportare tale portata rispetto a quella necessaria per 1.300.000 abitanti
(intero Abruzzo) con dotazione pro-capite-giorno di 250 litri, la portata necessaria sarebbe pari a
3,76 mc/sec, da elevare ad 8 mc/sec assumendo perdite nell’ordine del 50% e tenendo conto
dell’incidenza dei turisti nella stagione estiva.
Dunque, non c’è carenza d’acqua dal momento che la disponibilità è oltre sei volte
superiore alle necessità! Allora come mai vi sono problemi di approvvigionamento? Risposta
troppo facile:
- Inadeguatezza materica dei manufatti costituenti le reti idriche (ferro particolarmente),
divenuti incapaci di reggere le necessarie pressioni di esercizio indispensabili a fornire
acqua ai piani superiori delle abitazioni. - Inadeguatezza dimensionale degli stessi manufatti allorquando allungati a dismisura a
seguito dell’aumento della concentrazione di abitanti su nuovi quartieri. - Inadeguatezza della capacità gestionale riferita a interventi di riconsiderazione generale
delle reti cittadine di distribuzione idrica (la politica ha infarcito i soggetti gestori di pletore di personale, rendendo asfittico il bilancio degli Enti per quanto riguarda la loro capacità di
indebitamento a favore di nuovi interventi di ampliamento/raddoppio delle linee tubate) - Estrema difficolta d’intervento nelle aree urbane, tanto per le riparazioni che per sostituzioni
o raddoppi, tenuto conto che nel sottosuolo dei centri cittadini si intersecano sottoservizi di
vari gestori (metano, fogne e cunicoli delle acque piovane, cavi elettrici, fibre ottiche, allacci
privati etc.) di talché l’avanzamento di interventi è estremamente difficoltoso ed altrettanto
costoso.
L’insieme dei fattori appena elencati costituisce la matrice di tutti i problemi connessi alla
distribuzione idrica, che si vorrebbe risolvere facendo installare serbatoi ed impianti autoclave, cosicché i privati dovrebbero supportare con aumentati esborsi l’inefficienza complessiva della macchina gestionale (con maggiori costi di installazione e consumo di energia elettrica oltreché di diminuzione della qualità della risorsa utilizzata). I problemi della crisi di fornitura idrica non sono dovuti a mancanza d’acqua……..parliamo
d’altro!!!
In alcune aree territoriali della Regione (particolarmente nel basso chietino) è forse vero
come la diminuzione delle risorse sorgentizie possa generare limitazioni alla distribuzione di
un’adeguata dotazione di risorsa. Ma la tematica va affrontata in termini complessivi e non
facendo credere all’opinione pubblica che qualche pioggia in più possa risolvere il problema. Si
legge spesso, su tante testate, come l’evento piovoso venga ritenuto provvido rispetto
alle situazioni critiche che ormai occupano i media quotidianamente (sospensioni del servizio idrico in importanti aree territoriali). L’opinione pubblica deve essere informata rispetto ai fondamenti scientifici che regolano le portate delle sorgenti. Difatti, l’acqua che da esse sgorga ha una vecchiaia che può andare dai 5 ai 30 anni, vale a dire che l’acqua che (ad esempio) viene
pompata oggi dalle sorgenti del Tirino (pozzi San Rocco in Bussi) ha avuto origine da nevicate e
piogge (su Campo Imperatore) occorse tra 25 e 27 anni fa. Probabilmente, le sorgenti del Chietino hanno maggiore velocità di filtrazione, ma è inaccettabile che si possa ritenere di dover bere acqua piovuta la settimana prima.
Il controllo della datazione dell’acqua potabile è un tema che i gestori dovrebbero ben
conoscere! Prelevare un campione di acqua, inviarla ad un laboratorio qualificato (esempio CNR) per sottoporlo all’esame degli isotopi radioattivi del Tritio, costa qualche migliaio di euro, ma rende consapevole il gestore – confrontando i dati nivometrici e pluviometrici degli ultimi trent’anni – del possibile futuro andamento delle portate disponibili, conseguentemente consentendo la programmazione della realizzazione di nuovi adduttori capaci di trasferire acqua tra bacini diversi (da quelli più ricchi a quelli che si vanno impoverendo).
Volendo ulteriormente essere prudenti, sarà bene che i decisori pubblici valutino la possibilità di incremento di reti idriche duali (acqua non potabile derivata da corsi idrici superficiali e trattata in potabilizzatori per uso non alimentare) – come quella realizzata tra Chieti Scalo e Pescara – a far sì che gli usi non alimentari (sciacquone del water, lavaggi di piazzali e vetture, irrigazioni di piccoli orti etc.) vengano soddisfatti con acque di seconda categoria (a proposito è da tenere conto che rispetto ad una dotazione di 200-250 litri giorno/persona il solo sciacquone del water richiede tra 70 e 100 litri!). Abbassare la dotazione di acqua alimentare a 120-150 litri/giorno/persona dovrebbe essere l’obiettivo da raggiungere entro 10 anno a favore delle future generazioni.
Anche per questa tematica è bene soffermarsi – come bene ha fatto l’ex consigliera Sara
Marcozzi durante l’ultima consigliatura regionale – e riflettere sulle opportunità consentite alla
regione dalla ricchezza della sua risorsa, magari incentivando la costituzione di un Gestore unico a livello regionale (come imposto dalle norme in vigore) e organizzando un vero e proprio
“Assessorato alle risorse idriche” tale da programmare interventi su base ventennale e provvedere ai relativi finanziamenti avvalendosi di parte delle laute tariffe riscosse dai cittadini/utenti, oltre che di finanziamenti comunitari e statali che non tarderanno ad essere disposti in ragione delle vere problematiche che attanagliano alcune regioni del sud (Sicilia, Calabria e Puglia).
*Già direttore tecnico Consorzio di bonifica di Chieti