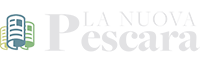di Gianni Melilla*
L’11 gennaio 1923 il Regio Decreto Legge 257 istituiva il Parco Nazionale d’Abruzzo già “sorto” il 9 settembre 1922 per iniziativa privata di Erminio Sipari, cugino di Benedetto Croce. La sua famiglia era la più importante dell’Alto Sangro e tra le più in vista dell’intero Mezzogiorno. Erminio Sipari fu il “padre” del Parco nazionale d’Abruzzo ed esprimeva in tempi così lontani una consapevolezza ambientalista forse più unica che rara : “Un Parco nazionale è un luogo di educazione nazionale inteso a suscitare il rispetto per le bellezze, per la grandezza e per l’importanza delle opere della natura, che sono puro patrimonio artistico e scientifico della Nazione”.
Il Parco Nazionale d’Abruzzo nasce quindi grazie alla lungimiranza di Erminio Sipari e sotto la sua guida muove i primi importanti passi. All’inizio è un piccolo territorio, poi nei decenni cresce spaziando dal Fucino all’Alto Sangro e abbracciando vari sottogruppi montuosi dell’Appennino abruzzese e poi anche laziale e molisano, dal Monte Marsicano al Monte Greco, dal Monte Genzana ai Monti della Meta, dal Monte Tranquillo al Monte Marcolano. Nel 1933, Sipari viene estromesso dall’Ente Parco Nazionale d’Abruzzo e la sua gestione passa alla Milizia Nazionale Fascista. È un vero colpo di mano orchestrato dal Ministro fascista all’Agricoltura e Foreste, l’abruzzese Giacomo Acerbo. Il Parco diventa una dependance di burocrati e politici fascisti. Anche nel dopoguerra le cose non cambiano e la Forestale continua a controllare il Parco. Sipari tenta nel 1951 con una istanza al Governo di farsi reintegrare alla guida dell’Ente Parco, ma non ci riesce.
Negli anni ’50 e ’60 potenti gruppi affaristici guidati da imprenditori napoletani e romani, esponenti della finanza vaticana, vari parlamentari, amministratori locali ed esponenti dell’Azienda di Stato per le foreste demaniali portano avanti progetti speculativi immobiliari soprattutto nella zona di Pescasseroli. A questi assalti reagisce la parte dell’opinione pubblica più sensibile alla difesa della natura. La campagna di stampa rilanciata dal settimanale L’Espresso e da vari quotidiani e riviste con l’impegno civile di giornalisti prestigiosi come Bruno Zevi e Antonio Cederna, si scontra con i vertici dell’Ente Parco occupati da un esponente aretino della Dc di Fanfani direttamente coinvolto nelle attività immobiliari. Dopo vari commissariamenti dell’Ente Parco e la sospensione del sindaco di Pescasseroli nel 1966 per abuso di potere in campo urbanistico le iniziative edilizie speculative e illegali si bloccano e si apre una nuova fase nella vita amministrativa dell’Ente Parco con la nomina nel 1969 a direttore dell’avvocato Franco Tassi.
Sino al 2002, Tassi dirige l’Ente Parco scegliendo finalmente una decisa impronta ambientalista che unisce alla rigorosa azione di tutela della natura una potente azione di promozione sociale ed economica di tutto il territorio del Parco nazionale d’Abruzzo. Progetti di tutela del lupo, dell’orso marsicano e del camoscio d’Abruzzo vengono conosciuti a livello internazionale e assunti come esempio mondiale di difesa di specie in via di estinzione. L’impatto in termini di immagine mondiale è straordinario. La migliore cultura ambientalista italiana segue e apprezza l’azione dell’Ente Parco nazionale d’Abruzzo. Nei paesi del Parco nascono i centri di visita, i musei, le aree faunistiche e didattiche, i camping, le aree attrezzate. I centri storici diventano alberghi diffusi, aprono attività commerciali ed artigianali. Le aziende zootecniche e agricole hanno un mercato di riferimento di centinaia di migliaia di visitatori che cercano prodotti tipici e praticano un turismo sostenibile.
Il Parco Nazionale d’Abruzzo diventa così non solo il più importante Parco Nazionale italiano e forse europeo, ma un centro di irradiazione e sperimentazione di un turismo verde e sostenibile, cioè di azioni economiche virtuose e alternative ai modelli speculativi e di saccheggio delle risorse naturali della montagna abruzzese.
Le generazioni studentesche che studiano e si laureano nelle università dopo il ’68 sono particolarmente sensibili ai temi ambientali e i giovani che tornano nei paesi dell’Alto Sangro negli anni ’70 presto diventano sindaci e amministratori dei vari comuni e insieme collaborano con l’Ente parco dando vita ad un’originale sperimentazione di ecoturismo e di sviluppo delle aree protette. Matura una nuova cultura ambientalista in tutto l’Abruzzo anche per la grande campagna popolare svolta dalla Cgil abruzzese che, assumendo come esempio di sviluppo il modello del Parco Nazionale d’Abruzzo, propone di creare un sistema regionale di Parchi e Riserve Naturali. È interessato tutto l’Appennino abruzzese e anche parte della costa. E questa battaglia viene coronata da un successo clamoroso. L’approvazione della Legge quadro nazionale 394 nel 1991 sulle aree protette consente infatti all’Abruzzo di aggiungere al suo storico Parco altri due grandi Parchi nazionali: Gran Sasso-Monti della Laga e Maiella-Morrone e qualche anno dopo un quarto Parco nazionale, ancora in itinere, della meravigliosa Costa Teatina. Ad essi si aggiunge l’Area Nazionale Protetta Marina del Cerrano sulla costa teramana.
Contemporaneamente la Regione Abruzzo si dota della Legge quadro sulle aree protette 38 del 1996 e nascono il Parco Regionale del Sirente-Velino e oltre trenta riserve regionali, dal Monte Genzana a Punta Aderci, dalle Sorgenti del Pescara alla Lecceta di Torino di Sangro, dalla Pineta dannunziana di Pescara alla Abetina di Rosello, dalle cascate di Zompo lo Schioppo a Morino al Bosco di don Venanzio, dal Lago di Penne al Bosco di Sant’Antonio a Pescocostanzo, dalle Sorgenti del Sagittario ai Calanchi di Atri.
L’Abruzzo ha scelto così di tutelare circa il 35% del suo intero territorio: un primato nazionale ed europeo.
Per questo l’Abruzzo può essere chiamato la regione verde dei Parchi.
Nei Parchi abruzzesi vivono decine di migliaia di persone che da millenni custodiscono questo immenso patrimonio non solo naturale, ma anche culturale ed economico. Basti pensare all’enorme valore degli allevamenti, alla bontà dei formaggi e delle carni. O anche al valore dell’agricoltura delle zone montane e alla tipicità dei suoi prodotti. O ai tanti mestieri di un artigianato di qualità del legno, del ferro, dei metalli preziosi.
La tutela della natura non ha per questo un aspetto solo vincolistico, ma si alimenta soprattutto di azioni volte a favorire la promozione sociale ed economica. Turismo, artigianato, agricoltura, zootecnia, servizi sociali, infrastrutture e nuove tecnologie sono le missioni degli enti gestori dei Parchi abruzzesi insieme alla protezione delle specie animali in via di estinzione, delle foreste e dei centri storici. Agli inizi di questa bella avventura vi è stata anche una certa ostilità almeno in una parte della popolazione, che non accettava i tanti vincoli, ma poi l’originale modello di sviluppo sostenibile dei Parchi ha portato benessere e questo ha consentito di apprezzare l’utilità di coniugare tutela ed economia.
La storia secolare del Parco Nazionale d’Abruzzo – dal 1991 ha aggiunto al suo nome anche Lazio e Molise – è stato un faro nazionale e regionale per la politica di gestione delle aree protette. La bellezza va tutelata e le popolazioni che custodiscono la bellezza del Parco Nazionale d’Abruzzo vanno sostenute perché consentono di tramandare alle future generazioni beni che appartengono all’intera umanità. Auguri dunque al Parco Nazionale d’Abruzzo, alle sue popolazioni, alle sue foreste, ai suoi lupi, orsi e camosci, ai suoi fiumi e laghi, ai suoi monti.
*Ex parlamentare e presidente emerito Consiglio Regionale d’Abruzzo